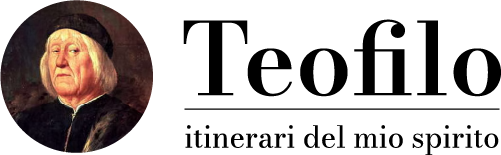“Mantua me genuit…” potrei dirlo anch’io come il mago Virgilio. No, eretico non fui mai. Anche se, quando mi ritrovai nel monastero (foto) di San Benedetto Po-Lirone (all’epoca nel paludario acquitrinoso della pianura oltre al grande fiume si formavano rivoli più o meno indipendenti, tra cui il Lirone, che oggi non esiste più) nel 1512, seppi che due anni prima vi aveva soggiornato Martin Lutero, nel suo viaggio verso Roma, e qualche sentimento lo aveva lasciato tra i confratelli.
No, nemmeno lussurioso; mio fratello Ludovico sì, era priore di San Benedetto Po-Lirone, quando venne espulso perché si diceva troppo attento alle donne pie.
Altro che rovi e spini, dove si avvoltolò, giovane ed eremita, il nostro padre fondatore, quando viveva nello Speco di Subiaco, mio fratello non si oppose alla tentazione. Io? Ero inquieto più per gola e per curiosità intellettuale; sì cari, checché ne pensiate il mio linguaggio maccheronico, che tanto piacque a Rabelais e a Erasmo da Rotterdam, era roba da cervello fine, non da cultura di serie B, anche il vecchio Ludovico Ariosto, che venne a Mantova nell’ultimo suo anno di vita (1533) mi benedisse, come letterato. Come poeta. Come collega.
Nel 1525 preferii lasciare l’ordine benedettino. Non dirò mai perché. Ma volevo vivere libero, nella crapula così come nello studio. La tonaca mi andava stretta, forse perché mi ero messo a mangiare troppo. Finsi persino di sposarmi (diedi anche un nome alla finta moglie: Girolama Dieda, io che mi chiamavo Girolamo, prima dei voti), ma era una delle tante maschere che mi piaceva mettermi in viso; così come per il nome. Io sono Merlin Cocai e Limerno Pitocco, non solo fra’ Teofilo, al secolo Gerolamo Folengo (1491-1544).
Continuavo a scrivere nel mio linguaggio finto, a metà tra il latino e il volgare, ma rigoroso, sia nella grammatica, sia nella metrica. Ero un perfezionista, affamato sempre di cose più buone. Mangiavo, scrivevo e leggevo tanto. Mi ero abituato bene nello scriptorium di San Benedetto Po-Lirone, dove c’era di tutto e di più, tanto da soddisfare anche il papa umanista, quel Pio II Piccolomini, che fece tappa tra nebbie e zanzare, lui che veniva da Pienza, pur di frugare tra i manoscritti copiati nel tempo dallo zelo dei nostri fratelli benedettini, prima che arrivasse la Commenda dei Gonzaga e la regola dei francesi di Cluny. Lasciato il convento insegnavo, come aio. Ma mi mancava il cenobio. Il 9 maggio 1534 fui riammesso nell’ordine, e dopo le mie solite peregrinazioni, finii vicino a Bassano del Grappa – non fate ironia, sulla grappa – dove sono morto e sono sepolto. E dimenticato, dai più.
Oggi da benedettino mi compiaccio che il padre fondatore sia divenuto patrono d’Europa – anche se, confesso, non so che cosa sia questa Europa, per me, per quello che sentivo raccontare, solo e sempre un grande campo di battaglia, con qualche abbazia e santuario e qualche città bella e qualche buon piatto da assaggiare – e soprattutto che la sua casa di Norcia, da tempo edificata come Basilica (foto) a lui dedicata, sia potuta risorgere (per la terza volta mi pare) dalla distruzione dell’ultimo terremoto. Giovedì 30 novembre sarà restituita a lui la memoria domestica, ai fedeli il luogo di culto, una meta spirituale ai pellegrini, pochi in verità, rispetto al gigante che era il nostro rigoroso fondatore.
Ho voluto fare questa incursione, a sorpresa perché chi legge i racconti del mio quasi conterraneo – Marco ci tiene a dirsi milanese, figlio di mantovani, ma milanese, ambrosiano – di me sa poco, credo. Quasi nulla.
Ho aggiunto poco. Ho preferito farvi vedere qualche immagine della chiesa abbaziale disegnata da Giulio Romano (qui lavorarono Correggio e Paolo Veronese), che sorse sui resti dell’oratorio romanico di Santa Maria (ancora visibile, direi bellissima), che a sua volta prese il posto di una cappella dedicata a San Benedetto (962). Tutto iniziò nel 1007, quando Tedaldo di Canossa, nonno paterno di quella che sarà la Gran Contessa Matilde (1046-1115), donò queste aree – venti chilometri a sud di Mantova, appena oltre il Po – alla comunità benedettina. Settant’anni dopo (1077) Matilde impose al monastero l’obbedienza al papa Gregorio VII. Anni di splendore, quasi tutti, ma all’inizio del Seicento tutto andò in crisi. L’abate di allora vendette le spoglie di Matilde, che rimase sepolta a San Benedetto Po-Lirone fino al 1632, a papa Urbano VIII che le tumulò in pompa magna in San Pietro.
Di quello che ho scritto, credo non vi interessi nulla, o quasi. Il mio Baldus (1517) è un anti-eroe, ma soprattutto un pretesto per sfidare il poema eroico (l’Eneide di Virgilio) con un registro pop, direste oggi, burlesco nel contenuto e nella lingua. Baldo è anche il nome dell’unico monte che si vede dalla piattissima pianura padana, qui dove il Po incrociava il Lirone, e dove sorse l’abbazia benedettina di cui vi ho detto. Se per caso vi capitasse di passare di là, magari in un giorno di infernale calura estiva, o in un gelido inverno nebbioso, sareste preda di un asfissiante piano orizzontale, schiacciati e oppressi dall’eternità; l’unico guizzo verticale che riuscireste a vedere è il profilo del monte Baldo, verso Verona, verso il Garda. Lo stesso guizzo che ho cercato di raccontare con l’omonimo improbabile eroe e la sua compagnia brancaleonesca. Poi ho scoperto che Dio – “Adoro te, devote, latens deitas” – è sia nel deserto orizzontale, sia nelle vette. E lo riconosce chiunque si lascia amare.